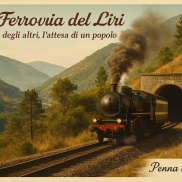ECONOMIA - LA FERROVIA DEL LIRI
- Tommaso Villa
C’è un filo di ferro, lungo e tortuoso, che unisce Avezzano ad Arce, passando per Sora e la Valle del Liri. Lo attraversiamo da sempre, distrattamente, senza sapere che quel tracciato è la fotografia perfetta di ciò che siamo: una terra laboriosa, ma spesso tagliata fuori dalle scelte che contano.
Quando la ferrovia nacque, alla fine dell’Ottocento, si parlava di progresso, di corridoi interni, di unità nazionale. L’Italia voleva collegare i suoi monti e le sue valli con nuove arterie di ferro, e la Valle del Liri, con le sue cartiere e i suoi lanifici, sperò di poterne finalmente trarre beneficio.
Ma la verità è che il progetto partì altrove, e per altri. La spinta arrivò dall’Abruzzo. Furono i proprietari del Fucino e i deputati dell’Aquila a chiedere una linea che collegasse la Marsica con la ferrovia Roma–Napoli, per portare al Tirreno i prodotti della bonifica voluta da Torlonia.
Serviva un collegamento verso ovest, non per l’industria, ma per l’agricoltura. E così la Valle del Liri, che avrebbe avuto bisogno di una ferrovia per le merci e per i lavoratori, si trovò nel mezzo di un progetto pensato per tutt’altro. Il primo tratto tra Roccasecca e Arce aprì nel 1884, poi la ferrovia salì fino a Sora (1891), toccò Balsorano (1895) e infine Avezzano (1902).
Un percorso straordinario dal punto di vista tecnico, con ponti, curve e gallerie scavate nella roccia viva. Emblematica è la galleria di Avezzano, considerata all’epoca un capolavoro di ingegneria ferroviaria: lunga, elicoidale, realizzata per superare un forte dislivello con una pendenza costante.
Un’opera maestosa, perfetta dal punto di vista tecnico, ma poco utile per il trasporto pesante che sarebbe servito alla Valle del Liri. Era la dimostrazione perfetta di una linea costruita con altri obiettivi e altre priorità.
Le industrie di Isola del Liri e di Sora continuarono infatti a muovere le merci con carri trainati da buoi, fino a Ceprano o Roccasecca, per immettersi sulla Roma–Napoli. I sindaci e i deputati locali, come Eugenio Tersenghi nel 1883, chiesero una diramazione diretta Isola del Liri–Ceprano, ma il progetto fu ignorato.
La Valle del Liri restò così servita da una ferrovia “di passaggio”, utile a chi veniva da fuori e penalizzante per chi produceva dentro. Oggi la linea sopravvive, tra chiusure e riaperture, più per memoria che per funzione.
I binari attraversano paesi che hanno dato tanto all’economia del Lazio meridionale, ma che non hanno mai ricevuto una politica capace di valorizzarli davvero.
Eppure, lungo quelle rotaie, la storia continua a parlarci: parla di una ferrovia nata per gli altri e rimasta ai margini, di amministratori che non hanno saputo piegarla alle esigenze del territorio, e di una valle che ancora aspetta il suo riscatto.